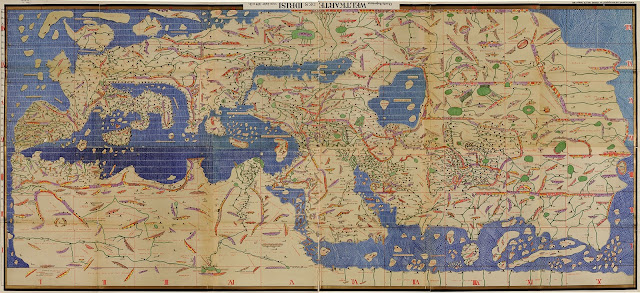Ero a Prato, qualche settimana fa, e per caso ho saputo che al Museo Pecci si teneva una conferenza dell'insigne sociologo Zygmunt Bauman. Mi è venuta la curiosità di andarlo a vedere, il vecchio, visto che ha una veneranda età, come si dice, e un'occasione simile avrebbe potuto non ripresentarsi. Tutto qui, solo per la curiosità di vedere il personaggio dal vivo: del suo pensiero mi importa il giusto, visto che la sua importanza è limitata all'invenzione di una metafora, quella della società solida (rappresentativa della modernità) e della società liquida (caratterizzata invece nella postmodernità). La metafora ha avuto successo, come sappiamo, tanto che il professore l'ha applicata un po' a tutto, scrivendoci libri che hanno scalato le classifiche grazie al potere immaginifico delle parole, esercitato soprattutto sulle masse di ignorantelli che non hanno letto Simmel, Weber, Mannheim e Ortega y Gasset (quelli importanti, insomma). Abbiamo perciò amore liquido, paura liquida, vita liquida e, ovviamente, modernità liquida.

Il titolo della conferenza al Pecci non era da meno, quanto a potere immaginifico: La fine del mondo.
Chi, tra i presenti, si attendeva una rivelazione o una premonizione di ciò che ci attende, tuttavia, è rimasto deluso. Perché l'anziano professore il binocolo non ce l'ha, o perlomeno ha lo stesso che abbiamo noi tutti.
Non mi soffermerei ora a parlare di Bauman, delle sue chiacchiere (dal momento che la sociologia speculativa è una scienza per modo di dire, di questo stiamo parlando: di chiacchiere) se non fosse per quanto ho appreso una settimana più tardi, durante il mio soggiorno a Roma.
Mi trovavo nella città eterna per seguire un laboratorio di sceneggiatura al CSC (il centro sperimentale di cinematografia). Una ragazza che partecipava con me a questo laboratorio mi ha rivelato che nel secondo episodio della serie I Medici (una serie prodotta da Rai Fiction), è accaduto qualcosa che pochissime persone avrebbero immaginato.
A quanto pare, assistiamo a una scena in cui Walder Frey propone a Robb Stark (che nella finzione medicea è in realtà Cosimo de' Medici), di sposare sua figlia, la Contessina de' Bardi.
Il popolo del web è esploso, inveendo contro la terribile invenzione. Probabilmente è ancora forte l'astio con cui i fedeli estimatori del Trono di spade ricordano il red wedding, l'evento in cui Robb Stark e i suoi cari sono stati massacrati. E ora, tali sentimenti sono rievocati in questo momento catartico, un deja-vu, che in realtà è qualcosa di più che un deja-vu.
Quel che importa, tuttavia, non è il momento in sé, ma l'effetto che voleva ottenere, che è stato l'origine delle scelte dei produttori della serie. Il popolo del web ha espresso la propria incredulità, il proprio sconcerto, pure l'indignazione, per quel che si è visto. Per alcuni sarà stato come infierire su una ferita ancora aperta.
E ora tutto sembra ripetersi: Robb Stark deve sposare la figlia di Walder Frey. Quel che c'è di diverso, oltre all'ambientazione, il contesto storico e i nomi dei personaggi, è che stavolta tutti sanno come andrà a finire. Tutti sanno che Robb sta commettendo un errore, e che di Walder Frey non c'è da fidarsi.
I grandi film, le grandi fiction, hanno il potere di sospendere la nostra incredulità. Una volta che ci siamo dentro, smettiamo temporaneamente di farci domande. Poco importa quanto sia realistico quel che vediamo. Quel che caratterizza l'offerta di matrimonio, qui, è il potere evocativo determinato dai due attori, che sono i soliti che abbiamo visto in una simile situazione, ma in altro contesto.
Possiamo ritenere che l'intercambiabilità dei contesti sia un connotato della postmodernità? Che le cornici che dovrebbero contenere le nostre visioni, le nostre emozioni, le nostre passioni, siano facilmente sostituibili, e addirittura se ne possa fare a meno? No, io credo di no. Credo che una cornice sia sempre necessaria. Perché la cornice serve ad articolare una storia. E' un elemento non trascurabile di qualunque narrazione. Serve a portarci all'interno della storia. Se non ci fosse, probabilmente non avremmo nemmero la percezione di seguire una storia raccontata.
Probabilmente il "C'era una volta" con cui le favole iniziano ha questa funzione, quella di condurci in un contesto estraneo alla realtà. Ripetere la scena in un altro contesto forse sminuisce la pretesa di sospendere l'incredulità dello spettatore. Quel che notiamo, alla fine di una lunga e incerta riflessione, è che ogni momento è potenzialmente catartico.
Tutto ciò è alquanto postmoderno, si è già detto. Eppure, c'è una cosa che si chiama immaginario, per il quale non è facile tracciare una mappa. Ciascuno ha i propri punti di riferimento, le proprie misure. Il mondo è multiforme, e dalle ventuno lettere dell'alfabeto sono fiorite parole di molteplici significati, innumerevoli linguaggi che cercano di abbracciare la vita e il mondo, ciascuno a modo proprio. Per quanto liquido possa essere l'immaginario, sembra che debbano esserci dei punti di riferimento solidi. Dopotutto, così è l'uomo. Forse è sempre stato così, anche nella notte dei tempi.
Forse siamo noi, oggi, nella notte dei tempi, in cui ci affidiamo a narrazioni che, senza nasconderlo, fanno della ripetizione il loro momento catartico per ragioni di marketing.
Marzio Valdambrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 Il mondo sta cambiando. Ecco, questo è un inizio promettente.
Il mondo sta cambiando. Ecco, questo è un inizio promettente.